
“Nelle situazioni di pericolo, l’opossum adotta come mezzo di difesa la tanatosi, ossia finge di essere morto”[i]
L’opossum nell’armadio è l’ultimissima raccolta di racconti di Lorenzo Spurio edita per Poetikanten Edizioni: ventuno racconti brevi che hanno come denominatore comune l’opossum. L’opossum è un animale che patisce la luce[ii]: questa è una delle primissime citazioni scientifiche che aprono ogni racconto della raccolta. L’opossum è un alter-ego e quindi non il vero personaggio narrativo dei racconti anche se presenzia alla scrittura e alla lettura degli stessi. In realtà l’opossum è un espediente letterario che vorrebbe mimare il comportamento della nostra psiche mettendola in relazione attraverso l’armadio-Io con la coscienza morale che si trova all’esterno e che freudianamente possiamo considerare il Super-Io. Almeno… io l’ho inteso così.
Viene spontaneo il paragone con il famoso scheletro nell’armadio, che ci fa immaginare la psiche come qualcosa da nascondere alla vista degli altri, dal giudizio di una coscienza morale rappresentata qui dalla collettività (e nel microcosmo del libro dallo stesso autore) , dalla relazione con il mondo esterno e da quell’insieme di fattori socio-culturali che condizionano le scelte di autocensura. L’armadio incarna la mediazione tra i bisogni pulsionali propri dell’Es (opossum) e il mondo esterno (Super-Io), sistema di censure che regola il passaggio dalle pulsioni dell’Es all’Io. Questa serie di censure o aperture impreviste mostrano al lettore i vari aspetti che fanno capo alla psiche-opossum, descritti in queste citazioni scientifiche di apertura che denotano la volontà dello scrittore di voler adottare un’insolita tecnica narrativa che -come scrive Susanna Polimanti nella sua postfazione –riceve ispirazione dall’etologia per prendere in esame una sorta di intersoggettività di comportamento.
Se l’opossum è un animale che patisce la luce, anche l’insieme caotico e turbolento delle nostre pulsioni, governato dal principio di piacere, che è l’Es, non desidera venire allo scoperto: è quello che Freud designava come la parte oscura di noi, al di fuori di ogni logica, di ogni moralità, di ogni definizione di bene o di male, ma anche spazio in cui le potenzialità espressive si formano e perciò luogo bianco, neutrale, in cui tutto è possibile. Sarà per questo che Lorenzo tiene a informarci che la parola opossum deriva dal termine algonchino [iii] “apasum” che significa “animale bianco”[iv]? Il bianco è il colore comunemente associato al settimo chakra che a sua volta si associa all’elemento pensiero e il cui sistema di riferimento è la corteccia cerebrale e il sistema nervoso centrale. Tuttavia l’ultimo chakra si colloca sopra la testa e quindi fuori della dimensione fisica vera e propria, così come la psiche che è considerata come l’insieme di quelle funzioni cerebrali, emotive, affettive e relazionali dell’individuo, che esulano dalla sua dimensione corporea e materiale.
L’insieme di queste funzioni psichiche viene egregiamente interpretata da un animale, l’opossum appunto che, visto in questa ottica (quella di un animale per altro anche simpatico) non dovrebbe essere giudicabile. L’autore vorrebbe quindi sottrarsi a qualsivoglia giudizio sui comportamenti che fanno capo all’opossum e quindi alla psiche dei suoi stessi personaggi? Oppure il suo giudizio è da ricercarsi non più tra le righe ma nel complesso della narrazione e nella sua strutturazione? A differenza dei racconti della cucina arancione (lavoro precedente di Spurio) sembra difficile qui scovare un giudizio implicito andando a leggere tra le righe della narrazione. Spurio, come vedremo, è del tutto coerente con il suo intento narrativo che emerge in maniera indiscutibile: presentare attraverso una crono-storia di rigore pseudoscientifico una narrazione da cui trarre proprie riflessioni.
Apparentemente non si evince alcun giudizio implicito o esplicito, se non quello eventualmente insito (che emerge però solo dopo riflessione) nella coscienza morale del Super-Io appartenente al lettore ma anche allo scrittore e agli stessi personaggi in quanto immersi e calati in un contesto socio-storico attualissimo e molto aderente al reale. L’opossum nell’armadio in questo senso si può considerare una fucina psicologica, un laboratorio di esperienze, laddove siamo in grado, attraverso la ricetta che l’autore stesso ci suggerisce ironicamente alla fine del libro, di cuocere a fuoco lento le pulsioni e le esperienze emotive, affettive, relazionali, nelle quali ci siamo riconosciuti attraverso la lettura, operando una sorta di esorcizzazione degli eventi più o meno irreparabili o spaventosi che fanno parte della psiche-opossum di ogni uomo.
Perché è certo: benché tendiamo ad allontanarci da taluni meccanismi che riconosciamo ben visibili nel diverso, ossia in colui che viola le norme sociali, senza mai comprenderne però il mistero, sostanzialmente siamo molto vicini a tutti i personaggi descritti in queste pagine che sono frutto non tanto di un’attenta osservazione quanto certamente di una riflessiva speculazione dell’autore sulla biodiversità della psiche umana. Chi è il diverso? Questa la domanda che, subdolamente, sale alla mente durante la lettura.
A questo proposito ho trovato interessante la citazione d’apertura che riporta le parole di Mario Tobino tratte da Le libere donne di Magliano: Il manicomio è pieno di fiori, ma non si riesce a vederli. Per Tobino l’essere umano deve mantenere intatto il suo diritto più grande e inalienabile che è quello di manifestarsi in libertà, anche nei deliri di una mente folle che, per lo scrittore viareggino, è il più grande mistero che accompagna l’esistenza. Questo ribaltamento del punto di vista o del giudizio morale sul malato psichico o, se vogliamo, sul diverso, collima sostanzialmente con l’espediente letterario dell’opossum che invita il lettore a sospendere il giudizio e a guardare meglio dentro di sé, ma anche dentro gli atteggiamenti dell’altro.
Forse mi troverò in disaccordo con molti dei pareri espressi su questo libro, ma vorrei soffermarmi su un aspetto che mi ha colpito di questa lettura. Non trovo che l’autore abbia ricercato una caratterizzazione interiore della psiche per indagare i vizi o le psicopatie del singolo personaggio come avveniva, invece, per La cucina arancione. E non è la psiche del singolo individuo che si vuole esorcizzare o eventualmente analizzare, ma è semmai la psiche collettiva, ossia l’insieme dei comportamenti e delle pulsioni che regolano e fanno parte di una coscienza comune: esistono almeno 130 specie di opossum scrive Lorenzo introducendo il racconto Due parole sulla biodiversità.[v]
Indubbiamente questi racconti devono portare ad alcune considerazioni e quindi non ritenere i contenuti superficiali o sufficienti ci avverte nella sua sintetica e acuta prefazione Marzia Carocci, e questo compito, non troppo ludico, è affidato completamente al lettore. Ancora una volta l’analogia e /o il confronto con il mondo animale ci permettono di guardarci da altro punto di vista. Non giudichiamo l’opossum, che è libero di avere quante più specie possibile- e per cui anzi la biodiversità è indice di ricchezza- ci permettiamo, però, di giudicare negativamente la biodiversità umana attraverso il razzismo e il disprezzo dell’alterità. Se non siete in grado di cucinare l’opossum, mi raccomando, tenetelo ben chiuso nell’armadio! Vorrà dirci questo l’autore?
Questa è solo una delle tantissime riflessioni che scaturiscono, o possono scaturire, anche e soprattutto per difetto, dalla lettura delle vicende narrate nei ventuno racconti. Il filo narrativo, infatti, si intreccia abilmente, al fine di portare alla luce eventi e situazioni che suggeriscono, senza palesarla, una interrogazione più intima e personale di tematiche importanti e profonde, attuali e atemporali. Manca il pathos, manca il dramma, manca il pensiero inconscio dei personaggi, manca la ricerca di una causa, di una verità, di una spiegazione e per difetto emerge attraverso questo contenitore di vuoti spaventosi il più grande spettatore onnipresente: la coscienza collettiva, quella mannaia impietosa che ri-getta il diverso fuori dal proprio utero.
Seguendo le teorie dello psichiatra scozzese Robert David Laing[vi] potrebbe essere un parto collettivo, un’espulsione fisiologica, una drammatica selezione naturale attraverso cui la psiche collettiva ci avverte di un disagio: il malato patologico o quello che diventerà tale grazie alle dinamiche sociali dell’emarginazione è un sintomo che ci avvisa di forti malanni e cancrene in seno alla collettività. Nell’ottica abituale di medicina allopatica occidentale occorre subito sopprimere il sintomo e quindi si procede all’espulsione immediata dalla cosiddetta civiltà.
In questa raccolta il tema dominante è rappresentato dall’imprevisto, ossia da quel battito d’ali di farfalla che può pesare positivamente o negativamente sull’agire umano. Non è tanto la psiche in sé a essere oggetto di attenzione mediante la descrizione minuziosa dei fatti quanto l’analisi che scaturisce dalla sua osservazione e la domanda che eventualmente potrebbe nascere da un imprevisto narrativo. Lo stile narrativo dell’autore è semplice e diretto, privo di pathos e di grandi sconvolgimenti emotivi, predilige la rappresentazione della vita di tutti i giorni, spesso in uno stile sfumato e dimesso, a tratti quasi noioso e pedissequo nel voler aderire alla realtà. Credo che sia questo il motivo per cui Lorenzo descrive, nella sua dedica personale, questi racconti come di taglio leggermente più intimista. Qui l’autore non subisce il fascino di ciò che è insolito, bizzarro, estraneo al proprio agire, ma riscopre e rivaluta il quotidiano, se vogliamo il banale e l’ordinario attualizzandolo in concetti riflessivi che emergono per difetto, ossia dalla minuziosa osservazione e descrizione dei fatti di ogni giorno, senza la pressione eccessiva di una descrizione giudicante, evitando di porre l’accento sulla psiche che –metaforicamente parlando- per tutto il libro resta ben chiusa dentro l’armadio.
Il peso della farfalla di Erri de Luca -per restare in tema di farfalle- pone l’accento sulle variabili minime che operano cambiamenti di peso consistente. Ora noi non siamo cervi e non viviamo nel bosco, ma se rappresentiamo la psiche come un bosco-mente e il cervo come il nostro Es che viene continuamente sollecitato da fattori variabili (farfalla) possiamo recepire questa similitudine come uno spazio introspettivo su cui riflettere. Certamente conoscendo la passione di Spurio per la letteratura inglese, in particolare per l’autore Ian McEwan, non posso non tenere conto dell’elemento imprevisto come studio letterario approfondito sul sociale. Mi è venuto spontaneo l’accostamento a un passo dell’Espiazione dell’autore inglese: “Mi ha sempre colpito pensare che qualcosa di molto piccolo, come non dire la parola giusta o non fare il gesto opportuno, può far prendere alle nostre esistenze una strada diversa. È una cosa che accade innumerevoli volte, ma ce ne accorgiamo appena. Succede anche a noi di tenere scrupolosamente dentro parole, frasi e sensazioni, nei nostri progetti, nella vita di tutti i giorni, nelle scelte fatte o rimandate, per non fare male agli altri. Ma non pensiamo mai che questo potrà cambiare il corso delle cose.”
In moltissimi racconti di questa raccolta di Lorenzo Spurio ho constatato come l’elemento imprevisto sia una chiave di lettura importantissima che ha guidato una riflessione forse molto meno scabrosa (rispetto alla cucina arancione) ma molto più intima sulle dinamiche che regolano gli scambi tra la propria personalità e quella di una collettività di cui comunque facciamo parte. Del resto l’opossum è un animale neofobico, cioè che mal si adatta alle novità,[vii] ci tiene a informarci Lorenzo Spurio suggerendoci anche, probabilmente, che ha paura dell’imprevisto. Imprevisto che è parte dell’intreccio e dello stile narrativo tanto da determinare finali a sorpresa e, in diverse occasioni, il ribaltamento d’opinione sui personaggi stessi che Spurio ha abilmente costruito come esseri credibili, calati nella realtà e facilmente assimilabili alle nostre abitudini, nonostante la finzione letteraria.
Se per La cucina arancione avevo individuato la catarsi come strumento di lettura e elemento distintivo di stile narrativo, e del resto lo stesso McEwan affermava, interrogandosi sul perché si scrive – e legge – di cose orribili, che “usiamo i casi peggiori per misurare la portata della nostra morale. E forse dobbiamo svolgere le nostre paure all’interno dei confini sicuri dell’immaginario, come forma di speranza esorcistica” per L’opossum nell’armadio –per cui questa affermazione potrebbe risultare altrettanto valida- ho creduto però di dare risalto alla frattura improvvisa che si può generare nel lettore attraverso il patto finzionale. Per frattura intendo, una sorta di insoddisfazione, di sorpresa, di interrogazione che emerge dall’osservazione e dalla conseguente riflessione su determinati eventi, ma soprattutto su certi comportamenti della psiche che coscientemente o meno sappiamo essere parte del nostro bagaglio socio-culturale.
Non è una mia idea: Emil Cioran, infatti, affermava “io credo che un libro debba essere davvero una ferita, che debba cambiare in qualche modo la vita del lettore. Il mio intento, quando scrivo un libro, è di svegliare qualcuno, di fustigarlo. Poiché i libri che ho scritto sono nati dai miei malesseri, per non dire dalle mie sofferenze, è proprio questo che devono trasmettere in qualche maniera ai lettori. No, non mi piacciono i libri che si leggono come si legge un giornale: un libro deve sconvolgere tutto, rimettere tutto in discussione.”[viii]
Se, dopo questa lettura, il vostro opossum si è finto morto emanando dall’interno del vostro armadio un inequivocabile odore di cadavere, non abbiate paura. E’ segno che è stata un’ottima lettura. E’ la ferita di cui parla Cioran, che attraversa la radice della sopravvivenza, il vostro Es, serbatoio di energia vitale che, pressato dalla coscienza morale del Super-Io e oscurato dall’armadio protettivo dell’Io, vi sta chiamando con la sua strategia migliore di sopravvivenza lanciandovi un segnale fortissimo: fai qualcosa sto morendo!
Se, viceversa, nessuna ferita, nessuna frattura, vi ha scosso dal vostro torpore, allora, regalate l’opossum nell’armadio ai vostri amici vegani…
[ n a n i t a ]
Ringrazio l’editore Gilberto Gavioli de Il foglio clandestino che mi ha offerto lo spunto per usare le parole di E. Cioran riportate in note
Note
[i]Citazione da Pag.121
[ii] Pag.17
[iii] originario e diffuso nel nord America
[iv] pag.107
[v] Pag.75
[vi] « Se la razza umana sopravvive, il futuro dell’uomo, suppongo, guarderà indietro verso la nostra epoca “illuminata” come un periodo di vero oscurantismo. I posteri con tutta probabilità saranno capaci di gustare l’ironia della situazione con più divertimento di quanto possiamo ricavarne noi. Rideranno di noi. Vedranno che ciò che chiamiamo “schizophrenia” era uno dei modi in cui, spesso attraverso persone alquanto ordinarie, la luce ha iniziato a irrompere attraverso le crepe delle nostre menti. »R.D. Laing, La politica dell’esperienza, p. 107
[vii] Pag.69
[viii] Un libro è una ferita di Emil M. Cioran
Lei ha scritto: «Un libro deve frugare nelle ferite, anzi deve allargarle. Un libro deve essere un pericolo». In che senso sono pericolosi i suoi libri?
Dunque, stia a sentire: mi è stato ripetuto più volte che le cose che scrivo nei miei libri non si dicono. Quando è uscito il Sommario (di decomposizione n.d.c.), il critico di «Le Monde» mi ha mandato una lettera di rimproveri: «Lei non si rende conto, questo libro potrebbe finire in mano a dei giovani!». Che assurdità. A cosa serviranno mai i libri? A imparare? No di certo, per imparare basta andare a scuola. No; io credo che un libro debba essere davvero una ferita, che debba cambiare in qualche modo la vita del lettore. Il mio intento, quando scrivo un libro, è di svegliare qualcuno, di fustigarlo. Poiché i libri che ho scritto sono nati dai miei malesseri, per non dire dalle mie sofferenze, è proprio questo che devono trasmettere in qualche maniera ai lettori. No, non mi piacciono i libri che si leggono come si legge un giornale: un libro deve sconvolgere tutto, rimettere tutto in discussione. Il motivo? Ebbene, io non mi preoccupo molto dell’utilità di quanto scrivo, perché veramente non penso mai al lettore: scrivo per me, per liberarmi delle mie ossessioni, delle mie tensioni e nient’altro. Poco tempo da una signora, nel «Quotidien de Paris», diceva di me: «Cioran scrive quello che ognuno si ripete sottovoce». Io non scrivo con lo scopo di «fare un libro», perché venga letto. No, scrivo per disfarmi di un peso. Soltanto dopo, meditando sulla funzione dei miei libri, dico tra me che dovrebbero essere come una ferita. Un libro che lascia il lettore uguale a com’era prima di leggerlo è un libro fallito.
Emil M. Cioran, Un apolide metafisico (Conversazioni), Adelphi, Milano 2005.





 María de los Remedios Alicia Rodriga Varo y Uranga (Anglès, 16 dicembre 1908 – Città del Messico, 8 ottobre 1963) , più conosciuta come Remedios Varo, fu una pittrice surrealista ispano-messicana, attiva soprattutto in Messico in collaborazione con Leonora Carrington. La loro amicizia, già iniziata in Francia negli anni ’30, si approfondisce straordinariamente negli anni del loro comune soggiorno messicano. A partire dal ’42 inizia infatti fra le due un sodalizio artistico che le porterà ad esplorare così in profondità la loro vita creativa al punto da creare un linguaggio pittorico comune. La loro affinità non si traduce, se non occasionalmente, in un lavoro comune, ma nella condivisione di una comune sensibilità e nello scambio di idee, storie e sogni, che le porta a condividere anche una vita creativa ispirata esclusivamente da un processo comune di scoperta del sé.Con la maturità e la lontananza il loro lavoro tenderà a divergere: sempre più complesso ed enigmatico quello della Carrington, più concreto quello della Varo. Nella storia dell’arte i loro nomi restano associati per aver fatto nascere, dalla forza della loro relazione creativa, uno stile pittorico unico e riconoscibile. (
María de los Remedios Alicia Rodriga Varo y Uranga (Anglès, 16 dicembre 1908 – Città del Messico, 8 ottobre 1963) , più conosciuta come Remedios Varo, fu una pittrice surrealista ispano-messicana, attiva soprattutto in Messico in collaborazione con Leonora Carrington. La loro amicizia, già iniziata in Francia negli anni ’30, si approfondisce straordinariamente negli anni del loro comune soggiorno messicano. A partire dal ’42 inizia infatti fra le due un sodalizio artistico che le porterà ad esplorare così in profondità la loro vita creativa al punto da creare un linguaggio pittorico comune. La loro affinità non si traduce, se non occasionalmente, in un lavoro comune, ma nella condivisione di una comune sensibilità e nello scambio di idee, storie e sogni, che le porta a condividere anche una vita creativa ispirata esclusivamente da un processo comune di scoperta del sé.Con la maturità e la lontananza il loro lavoro tenderà a divergere: sempre più complesso ed enigmatico quello della Carrington, più concreto quello della Varo. Nella storia dell’arte i loro nomi restano associati per aver fatto nascere, dalla forza della loro relazione creativa, uno stile pittorico unico e riconoscibile. (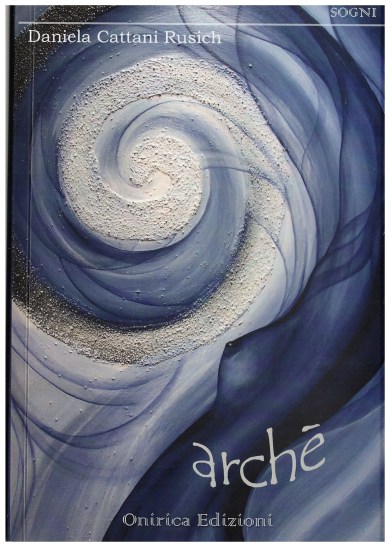
 Daniela è scrittrice, poeta, pubblicista, editor e performer, collabora con Onirica Edizioni come editor e direttore creativo, realizza videopoesie, videoletture e segue progetti collettivi. Partecipa spesso a eventi, reading, presentazioni e performance, che organizza anche per altri autori. Nasce a Milano, da madre greca e padre friulano. Dopo aver frequentato lo IULM, si specializza in relazioni pubbliche e fa praticantato presso due testate locali della provincia di Milano, ottenendo il libretto di pubblicista.
Daniela è scrittrice, poeta, pubblicista, editor e performer, collabora con Onirica Edizioni come editor e direttore creativo, realizza videopoesie, videoletture e segue progetti collettivi. Partecipa spesso a eventi, reading, presentazioni e performance, che organizza anche per altri autori. Nasce a Milano, da madre greca e padre friulano. Dopo aver frequentato lo IULM, si specializza in relazioni pubbliche e fa praticantato presso due testate locali della provincia di Milano, ottenendo il libretto di pubblicista.




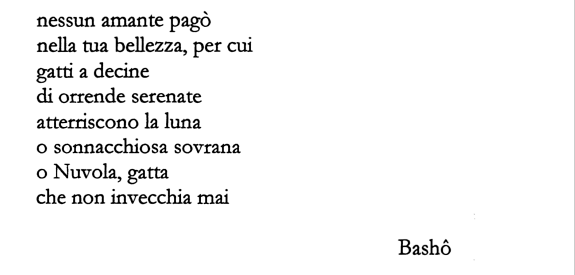











Devi effettuare l'accesso per postare un commento.