L’Italia è un bosco
recensione a cura di Valentina Meloni
“Il bosco è un universo di significati, di citazioni, di immagini, di sensazioni e di ricordi.
E’ una delle parole più presenti nell’esistenza di tanti.”
(T. Fratus, L’Italia è un bosco)[1]
L’Italia è un bosco, ed è bene ricordarlo, perché nonostante non si faccia altro che parlare di alberi, di boschi e di natura è bene che ci sia qualcuno che ce li racconti davvero, che nei boschi ci sia stato, abbia camminato, che abbia parlato, abbracciato, amato gli alberi e che sappia chiamarli con il loro proprio nome. “La conoscenza botanica non è una forma di sapere scientifico, nozionistico; è innanzitutto un sapere artistico: significa avvicinarsi al disegno di Dio o a quello dello spirito della Madre Terra(…) saper riconoscere una specie, attribuire un nome preciso, distinguere le forme e i colori delle foglie, le geometrie dei semi e dei fiori, le architetture dei tronchi e le manifestazioni grottesche dei grandi alberi antichi. Non è mera scienza: è arte, è poesia, è letteratura!” [2]
Lo ricorda Tiziano Fratus[3] nella sua ultima fatica letteraria corredata da sedici splendide fotografie che è a metà tra la passeggiata filosofica e un percorso naturalistico-spirituale: “L’Italia è un bosco” non è una guida, è un modo, è un aiuto a incontrare gli alberi […] è un libro filosofico come ci racconta la giornalista e scrittrice Loredana Lipperini in Fahrenheit.
Leggendo questo passo mi viene in mente la critica di “indeterminatezza” che Irène Némirovsky muoveva a Leopardi[4] e l’altra autocritica, più recente, di un caro amico scrittore e poeta che, mentre passeggiavamo insieme per Villa Demidoff, denunciava la sua grave mancanza nel non conoscere “il nome “ degli alberi. E’ vero si perde la poesia in questa indeterminatezza, una poesia che può essere persino antidoto al dolore. “ I parchi romantici-scrive Tiziano- che decorano le ville storiche sono stati decorati per narcisismo, molto spesso per vanagloria, per ostentare la grandezza del casato, oppure per vero amore nei riguardi degli alberi. Ma non rari sono i casi in cui alla base della decisione sta un dolore, come se piantar siepi di bosso, filari di carpini e boschetti di specie esotiche fosse l’antidoto giusto per curare un buco nell’anima”.[5]
Fratus ha un percorso poetico di tutto rispetto e io ho apprezzato la sua poesia prima della sua prosa, prima di arrivare a capire che per far parlare il paesaggio necessitano parole semplici e termini scientifici, gambe forti e perseveranza. Il suo scrivere è un tornare autentico alla terra, laddove la minuziosa descrizione del sentiero per raggiungere i luoghi dell’anima si unisce alla profondità della riflessione filosofica e alla poesia della parola che indugia nel particolare, nell’apparente insignificante che sfugge alla disattenzione; parola che si fa armonia nel proprio percorso d’introspezione, e canto di conciliazione nel perfetto incastro tra uomo- radice e paesaggio: ”L’alfabeto degli alberi sta sfumando nella canzone delle foglie” (William Carlos Williams.)[6].
E’ uno scrivere pungente quello di Fratus, ricco di spunti di riflessione, di satira e piccole critiche puntuali, uno scrivere non solo poetico nell’accezione poetica che siamo abituati a pensare, ma vero, terragno, senza fingimenti, laddove descrivere la natura significa anche dover piegar la schiena alla sua grandezza, alla fatica e ai sacrifici che sono necessari persino per goderne…
“Oggi si fa tanta filosofia sul ritorno alla terra e sulla poeticità del lavorare la terra, ma chi ne parla non ha mai dovuto piegare la schiena, non sa quanta fatica e quanti sacrifici si devono fare per avere un raccolto dignitoso. E’ uno dei tarli della nostra epoca, che l’università e certe scuole formino l’idea che la terra sia diversa da quel che è.”[7]
Mi piace Tiziano, ormai lo sanno tutti, mi piace perché è una di quelle persone che dice (scrive!) quello che pensa, e ancora di più perché è uno scrittore sui generis che non vuole imitare nessuno, che è consapevole di quello che è, della sua provenienza e che ha un proprio percorso, dinamico, eclettico, randagio, caotico e rivoluzionario nella sua perseverenza. “Mio padre era falegname. Sono cresciuto con addosso l’odore del legno lavorato.(…)Ho il rimorso di non aver appreso i rudimenti del mestiere da mio padre, anche se si tratta di un sentimento che si smorza quando penso alle mani dei miei…”[8] Fratus scrive di pancia, di testa e di radice, è un poeta, un uomo vero collegato al paesaggio vero, che non fa una moda di quel che è e di cosa fa, ma che trova la sua dimensione in ciò che gli piace e che lo fa stare bene.
“Viviamo in un’epoca di ritorno ai boschi, alla campagna, alla natura. (…) Mi chiedo però quanto ci sia d’autentico in questa moda. (…) Sto covando l’idea che spesso si tratta di natura “in prestito”: la tagliamo su misura, striscioline composte e ordinate che poi depositiamo con cautela su un tavolo trasparente, in accordo con le attuali categorie sociali e filosofiche, ma fors’anche più estetiche e comunicative. (…)La nostra è una natura addomesticata, da cartolina, che ci serve più di quello che realmente sta là fuori. È tanto semplice capire che nei nostri passi non siamo l’inizio e non siamo la fine di niente: è una constatazione facile da fare frequentando la natura, immergendosi in quel che chiamiamo natura. L’umiltà che ne dovrebbe derivare spesso collide con l’esaltazione dell’ego, che invece oggi la fa un po’ da padrona ovunque.”[9]
Umiltà è ciò che si respira in questa passeggiata filosofica che ci accompagna a conoscere gli alberi, Fratus li descrive con una misura poetica, annotando con minuzia ogni particolare del paesaggio che lo fa vibrare di vita, e queste vibrazioni passano al lettore pressoché intatte, come se egli stesso fosse presente a quell’incontro. “Oggi che i boschi hanno smesso di vestirci, di nutrirci, di proteggerci, sono diventati palestre dell’anima, è qui che possiamo venire ad alleggerirci, a sgrassare via il nero, l’ossessione, la furia. Provare davvero a vigilare sui nostri pensieri come un pescatore vigila sui pesci di cui si nutrirà”[10]
Ma gli alberi sono esseri vivi e hanno una storia per chi la sa raccontare, Tiziano ce la racconta con semplicità attraverso i suoi propri occhi; gli alberi a ben guardare sono una bellissima metafora esistenziale, hanno una nascita, una vita, malattie e infine muoiono anche loro come noi… Far vivere gli alberi anche dopo la loro morte, tramandare la loro storia, è un percorso culturale che ci ricongiunge al paesaggio e che ci rende armonici con la natura.
Arrivato alla Selva di Chambons, Fratus assiste alle conseguenze di una tempesta che si è abbattuta sul larice più antico e ce la descrive nella sua furia distruttiva, ma resta il ricordo di quel che resta e vivo nelle parole; mi conforta sapere che qualcuno ha ancora il sapore del ricordo da mantenere in vita: “Se avrò mai dei figli, un giorno, li porterò qui e gli racconterò di un gigante che in questo punto delle Alpi è vissuto per cinque o sei secoli, un monumento della natura amato da gente dal cuore puro”.[11]
Fratus è un uomo che attraversa il paesaggio alla ricerca di connessioni spirituali[12], le cerca e le trova e le descrive con sapienza attraversando quei luoghi in cui la storia degli uomini s’incrocia con quella della natura. Così nel silenzio elementare della foresta del Latemar[13]dai cui legni ad anelli sottili e regolari i liutai hanno per secoli ricavato il legno per realizzare violini, cetre, contrabbassi, arpe e altri strumenti, Tiziano ci riporta alle suggestioni del luogo che passano dal mistero alla poesia, dalla tragedia alla leggenda con la disinvoltura propria che sempre accompagna questi boschi. ”Ritrovo alcuni larici innevati ancora gialli in punta, uno sposalizio perfetto di sfumature questo che si viene a creare fra il bianco immacolato della neve e il giallo gonfio d’autunno. Ho sempre pensato che le conifere si esaltino sotto la neve, è come se non aspettassero altro, di metter su l’abito buono, quello giusto per andare al Gran Galà del generale Inverno. La neve esiste per saltare la bellezza delle conifere e le conifere esistono per esaltare la bellezza della neve”[14].
Questa suggestione della neve l’ho provata di persona diversi anni fa lungo le rive del Lago di Carezza (ma anche in altri luoghi) e quando ho letto questo capitolo, sono tornata ai miei ricordi e ho pensato che io stessa, rapita dallo stupore, non ho mai saputo descriverli in alcun modo, presa da una sorta di “rigor pulchritudinis”, resa impotente dalla sublime bellezza che c’è nella semplicità delle cose. Ho una predilezione per le conifere da quando sono bambina e leggere questo passo mi ha fatto vibrare l’anima come fosse un arco di violino di quel legno tagliato e cesellato da maestri, ma prima ancora dal vento, dall’acqua, dalla neve e dal silenzio della foresta. Anch’io, come te Tiziano, resterei lì in eterno, in attesa che dai piedi si gettino radici.[15]
“In questa foresta-continua Fratus- non c’è bisogno di andare a cercare alberi straordinari, è già tutto monumentale. Quel che osservo è il bianco sonoro che ama Davide Sapienza: sarebbe felice come un bambino se fosse qui con me, saremmo due bambini felici che si tengono per mano in questo spettacolo senza tempo“.[15 b]
Questa citazione per me racchiude una filosofia di vita , se vogliamo definirla così, in cui ho scelto di vivere per la maggior parte del mio percorso di osservazione naturalistica. Prediligo i grandi boschi ai grandi alberi monumentali, i monumenti collettivi a quelli solitari, perché ho sempre visto l’albero come una parte del tutto, protagonista insieme ai suoi fratelli e all’intero ecosistema del benessere collettivo e del percorso storico, religioso, sociale dell’intera vita sulla Terra. Le alberografie dei grandi alberi monumentali hanno una grande importanza, sia ben chiaro, e nutro un vivo interesse per tutto ciò che li riguarda, la loro storia deve essere trasmessa e divulgata e tutelato il loro benessere, ma la stessa rilevanza, a mio parere, deve essere riconosciuta agli ecosistemi delicati e ai grandi organismi viventi che sono le foreste e i boschi nella loro interezza. Sono essi stessi monumenti viventi e i grandi alberi monumentali a loro tempo sono stati, in alcuni casi, parte di questi grandi ecosistemi.Riconosco la rilevanza culturale de “L’Italia è un bosco” anche per questa attenzione alla “collettività arborea” che tanti appassionati apprezzano da anni nella loro piccola storia di uomini e donne radice.
“Vengo da un mondo di uomini dove sono nato e in questo mondo mi consumerò, anche se nel sangue allevo abeti e coni di sequoia”. [16]Scopro così che anche Tiziano probabilmente ha una predilezione per le conifere, e che non è un albero ma, come tutti i veri poeti, tende ad assomigliargli, e a confondersi con il paesaggio.
Tuttavia è su di una radice di ginepro secolare, ginepro licio (Juniperus phoenicea) per la precisione, che l’Homo Radix si chiarisce sulla differenza abissale fra l’idea di poeta che matura in ambito editoriale e letterario e l’idea del poeta che vive nel mondo reale[17]. Sotto la cupola di questo antico ginepro potrete leggere le note scritte di coloro che vengono ad omaggiare Tziu Efisiu Sanna, uno di quei poeti veri, morto pochi anni fa, non di lettere, ma di vita, un uomo che rifiuta la società, che ne contesta valori e dinamiche, che volutamente vive ai margini, ed è un cantore della semplicità e della libertà[18]. E’ così che un albero diventa la casa del poeta, Efisio, che per dieci anni ci vive assieme alla moglie per difenderlo dalle speculazioni ordinarie a beneficio degli idoli del dio denaro …e poi ci torna, nella vecchiaia, per raccontare agli ospiti la storia, la storia di un albero, la storia della Casa del Poeta.
Una storia che sopravvive ai protagonisti, è questo che mi apre il cuore alle possibilità della parola, ”Un omaggio ai grandi slanci, alle idee e ai sogni. Ai poeti del quotidiano. Ai “vincibili” dunque…” come scriveva Cervantes[19], perché, “Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.”[20]
Voglio terminare il viaggio attraverso i boschi d’Italia con le stesse parole di Fratus che in quei boschi ci invita saggiamente a perderci:
“Questo libro è un invito a fermarsi e a perdersi tra i tanti boschi e parchi d’Italia, a lasciarsi andare di fronte al vento forte, quando l’elettrostaticità dell’aria ti avvicina alle altre creature. È un invito a riconoscere altri tracciati rispetto a quelli urbani più consueti, e a ritrovarsi immobili di fronte all’urlo silenzioso di un cielo infuocato al tramonto, quando non sai come abbracciare tutto quel colore che brilla, che luccica, che sprigiona energia, che ti cattura e t’inchioda, che ti apre i polmoni e ti spalanca gli occhi… quel mare dove l’universo che conosciamo nasce e muore ogni santo giorno.”[21]
(Valentina Meloni)
Note
_____________________________________________________________________
[1] Introduzione XV
[2] Introduzione XVII
 Tiziano Fratus (1975, Bergamo) ha abituato i suoi occhi di bambino alle distanze della pianura e li ha corretti in adolescenza sulle colline del Monferrato. Studi irregolari, è sempre stato inquieto finché non ha iniziato a viaggiare per assaggiare la polvere di minuti spazi teatrali e promuovere le traduzioni delle proprie opere in versi. Ha fondato il Festival Torino Poesia che ha diretto per quattro anni e le annesse edizioni.Le sue “poesie creaturali” sono state pubblicate in vari volumi – Il molosso (2005), Nuova Poesia Creaturale (2010), Creaturing. Selected Poems (2010), Gli scorpioni delle Langhe(2012) – tradotte in sette lingue, sono apparse in antologie e riviste internazionali. La nuova raccolta, Un quaderno di radici, uscirà nella collana Zoom Poesia di Feltrinelli.Durante i viaggi in nord America, Europa e sud est asiatico ha iniziato a visitare i grandi alberi e a perdersi nel silenzio cantato dei boschi vetusti, partorendo i concetti di Homo Radix e alberografia che hanno fecondato quindici titoli, mostre fotografiche, itinerari disegnati in varie città e regioni, oltre alla rubrica “Il cercatore d’alberi” sulle colonne del quotidiano “La Stampa”. Fra i suoi precedenti libri si ricordano Manuale del perfetto cercatore d’alberi (Feltrinelli), Il sussurro degli alberi (Ediciclo) e l’illustrato per bambini Ci vuole un albero (Araba Fenice). Ampia è anche la sua produzione in versi, con traduzioni in otto lingue; fra le sue raccolte la più recente è Un quaderno di radici e foglie. Conduce passeggiate alla scoperta dei grandi alberi.
Tiziano Fratus (1975, Bergamo) ha abituato i suoi occhi di bambino alle distanze della pianura e li ha corretti in adolescenza sulle colline del Monferrato. Studi irregolari, è sempre stato inquieto finché non ha iniziato a viaggiare per assaggiare la polvere di minuti spazi teatrali e promuovere le traduzioni delle proprie opere in versi. Ha fondato il Festival Torino Poesia che ha diretto per quattro anni e le annesse edizioni.Le sue “poesie creaturali” sono state pubblicate in vari volumi – Il molosso (2005), Nuova Poesia Creaturale (2010), Creaturing. Selected Poems (2010), Gli scorpioni delle Langhe(2012) – tradotte in sette lingue, sono apparse in antologie e riviste internazionali. La nuova raccolta, Un quaderno di radici, uscirà nella collana Zoom Poesia di Feltrinelli.Durante i viaggi in nord America, Europa e sud est asiatico ha iniziato a visitare i grandi alberi e a perdersi nel silenzio cantato dei boschi vetusti, partorendo i concetti di Homo Radix e alberografia che hanno fecondato quindici titoli, mostre fotografiche, itinerari disegnati in varie città e regioni, oltre alla rubrica “Il cercatore d’alberi” sulle colonne del quotidiano “La Stampa”. Fra i suoi precedenti libri si ricordano Manuale del perfetto cercatore d’alberi (Feltrinelli), Il sussurro degli alberi (Ediciclo) e l’illustrato per bambini Ci vuole un albero (Araba Fenice). Ampia è anche la sua produzione in versi, con traduzioni in otto lingue; fra le sue raccolte la più recente è Un quaderno di radici e foglie. Conduce passeggiate alla scoperta dei grandi alberi.
[4] “l’errore dell’indeterminatezza, per la quale, a modo d’esempio, sono generalizzati gli ulivi e i cipressi col nome di alberi, i giacinti e i rosolacci con quello di fiori, le capinere e i falchetti con quello di uccelli. Errore d’indeterminatezza che si alterna con l’altro del falso, per il quale tutti gli alberi si riducono a faggi, tutti i fiori a rose o viole (…), tutti gli uccelli a usignuolo”.(Irène Némirovsky)
[5] Pag.45-46
[6] Citazione riportata da pag. 65
[7] Introduzione XV
[8] Introduzione XV
[9] Introduzione XVIII-XIX
[10] Introduzione XV
[11] Pag.11
[12] Introduzione XII
[13] Cap.6 pag.19
[14] Pag.21
[15] Pag.23
[15 b] Pag.22- Davide Sapienza (Monza, 1963) è uno scrittore, traduttore, giornalista e viaggiatore italiano autore di svariati libri tra cui “La musica della neve”, Ediciclo Editore,
[16] Introduzione XII
[17] Pag.140
[18] Pag.140
[19] “Ai poeti del quotidiano” Miguel de Cervantes,- “Don Chisciotte”
[20] Dal discorso di John Keating interpretato da Robin Williams nel film “L’attimo fuggente”
[21] Introduzione


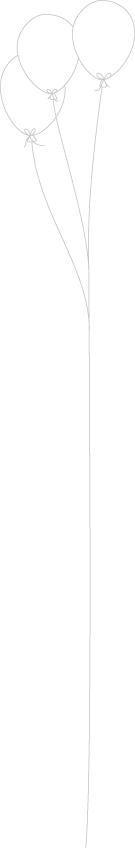
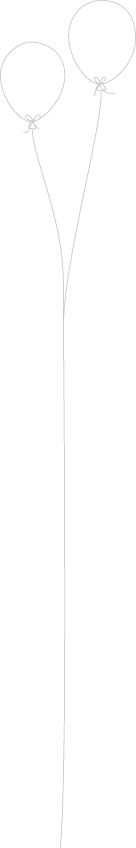
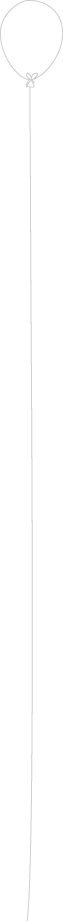
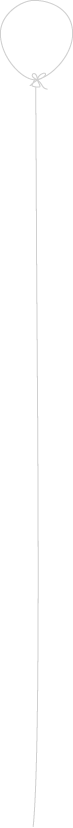
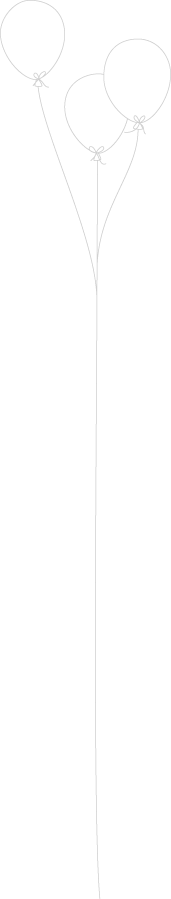
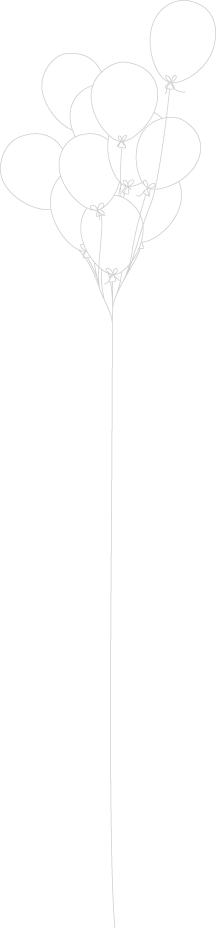
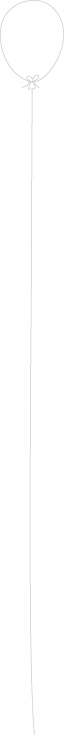
L’ha ribloggato su alessandrapeluso.
"Mi piace""Mi piace"
Il reblog di Homoradix alla mia recensione : “Valentina Meloni, appassionata di natura e animatrice del blog «Quelli che parlano agli alberi», ha dedicato gentili parole all’ultimo libro di Tiziano Fratus, L’Italia è un bosco, uscito per Laterza.”
http://homoradixnew.wordpress.com/2014/08/15/litalia-e-un-bosco-recensito-in-quelli-che-parlano-agli-alberi/
"Mi piace""Mi piace"
Pingback: Il libro delle foreste scolpite | valentinameloni
Pingback: L’Italia è un giardino (Tiziano Fratus) | n a n i t a