Il titolo Breviario antalgico di Alessandro Camilletti rivela già nella sua composizione una tensione tra cura e ascesi. Il breviario, plaquette di quindici poesie arricchite dagli enigmatici disegni dell’artista e poeta Gian Ruggero Manzoni, è il libro della preghiera quotidiana, della disciplina interiore; l’aggettivo antalgico, proprio del linguaggio medico, designa ciò che allevia il dolore. Ne scaturisce un ossimoro fertile: un libro che è insieme farmaco e rito, parola che lenisce attraverso la concentrazione, non l’espansione.
Le epigrafi poste in apertura disegnano il tracciato di una geografia spirituale che unisce Oriente e Occidente, sapienza antica e consapevolezza moderna. “La grande parola è luminosa; la piccola è prolissa”, afferma Zhuang-zi, e in questa sentenza è già contenuto l’intero progetto poetico di Camilletti: cercare la luce nel poco, la verità nella misura. A seguire, Schopenhauer ammonisce che “non si può servire al tempo stesso due padroni così diversi come il mondo e la verità”: il poeta sceglie chiaramente il secondo, rinunciando alla cronaca per un linguaggio spoglio, interrogativo, talvolta oracolare. Infine, Andrea Emo riconosce che “è distruggendo il nostro dolore che noi facciamo della poesia”: la sofferenza non è negata, ma attraversata fino al suo annullamento.
Camilletti costruisce così un breviario della coscienza in cui la forma breve, quasi aforistica, diviene pratica di conoscenza. Non vi è sviluppo discorsivo, ma successione di frammenti che si illuminano reciprocamente, come lampi nel pensiero. “La verità è risplendere della necessità”, afferma l’esergo di Nicolás Gómez Dávila, e il verso poetico si fa strumento di tale risplendere, non dichiarazione ma rivelazione.
La scrittura di Camilletti si situa in una linea che va da Eraclito ai pensatori orientali del Tao, fino al Bashō maturo, quello dei taccuini di viaggio e dei versi che coincidono con la percezione pura.
Nei componimenti più scarnificati, come
“Scoprendo / Copre”
“Eroico o vile, / ogni gesto si dissolve”,
ritorna l’eco della saggezza taoista, per la quale il sapere autentico si manifesta come sottrazione, e la verità coincide con il vuoto. Il poeta, come nel Tao Te Ching, sa che “chi sa non parla, chi parla non sa”: la parola, ridotta al suo minimo respiro, tende al silenzio.
L’intero libro si regge su un ritmo binario di opposizioni: “L’alto / Il basso // Vicino e lontano”, “Divora e spinge / La volontà”, “Scoprendo / Copre”. È in queste polarità che si dispiega la tensione del pensiero poetico, il tentativo di abitare la contraddizione senza risolverla. L’unità non è mai data, ma cercata nell’oscillazione. Il mondo, scrive Camilletti, è “un susseguirsi di guasti / il nostro trionfo”: la frattura è riconosciuta come condizione necessaria, non come errore da correggere.
Nella seconda parte, introdotta da un altro frammento di Gómez Dávila – “La maturità dello spirito comincia non appena smettiamo di sentirci incaricati del mondo” – la poesia assume un tono più umano, di lenta resa e trasfigurazione. La lingua si fa più mobile, attraversata da un ritmo respiratorio che ricorda il principio zen del mujo, l’impermanenza:
“Riparare ferite
Ricucire strappi
…
Lasciar
Evaporare il risentimento
Dissolvere il rammarico.”
Il gesto poetico diventa qui un atto di distacco consapevole, di dissoluzione del dolore nell’accettazione. Come in certa poesia giapponese — da Saigyō a Ryōkan — il poeta esercita la propria mente come si affila una lama: per ottenere il vuoto, per rendere la parola trasparente.
Il riferimento finale “a Friedrich Nietzsche” suggella un dialogo silenzioso con l’Occidente: la ricerca della leggerezza dopo il peso, la riconciliazione col divenire. In fondo, Breviario antalgico è anche un cammino di trasformazione del dolore in lucidità, un itinerario verso la pace della necessità:
“Nelle pause la poesia
Nei silenzi la sapienza
Nel respiro l’essenza.”
In questi versi conclusivi si condensa la lezione più profonda del libro: la poesia come via del respiro, come sospensione che non è assenza ma presenza più piena. Camilletti sembra ritrovare, nel gesto della concentrazione, quella “grande parola luminosa” di cui parlava Zhuang-zi: non verbo che spiega, ma luce che accoglie.
E a proposito di Nietzsche e della brevità che contraddistingue la scrittura di Breviario antalgico e che ha esaminato così bene Adriana Gloria Marigo nella sua eccellente nota “La nitida, incisiva proporzione spirituale della brevitas”, non si deve pensare che Alessandro Camilletti non abbia meditato la sua scrittura, che i suoi versi non siano frutto di una accurata introspezione: la brevità è per Camilletti una scelta stilistica di forma che abbraccia un contenuto fatto di silenzi e spazi bianchi (si veda come è strutturato il libro), di figure che lasciano spazio a un’interpretazione personale (i disegni di Gian Ruggero Manzoni) e di una scrittura meditativa che apre al lettore visioni e suggestioni e che, a sua volta, invita alla meditazione.
“Contro i biasimatori della brevità. Una cosa detta con brevità può essere il frutto e il raccolto di molte cose pensate a lungo: ma il lettore che in questo campo è novizio e non ha ancora affatto riflettuto al riguardo, vede in tutto ciò che è detto con brevità qualcosa di embrionale, non senza un cenno di biasimo per l’autore, che gli ha messo in tavola per pranzo, col resto, simili cose non finite di crescere, non maturate.” FRIEDRICH NIETZSCHE, Umano troppo umano II, 1879/80.
Il compiersi della tensione lirica, che è una piccola illuminazione, è lasciato con cura al lettore che deve cogliere, nelle suggestioni operate dalla poesia, il punto di incontro con le proprie emozioni ed esperienze e trasformarle in dialogo silenzioso con l’autore.
Breviario antalgico è dunque un testo liminare, scritto al confine tra pensiero e intuizione, tra ferita e cura. Come in certi sutra zen o nei koan, la forma breve diventa veicolo di una sapienza senza dogmi: l’insegnamento non è detto, ma si lascia intravedere, come il riflesso di una pietra bianca nel giorno perfetto.
“Il sole accarezza la piazza
Levità e dolcezza incorniciano
Il planare dei colombi sulla fontana”
*
“Continui assestamenti
Levigano il dispiacere
Una pietra bianca
É il giorno perfetto”
nanita


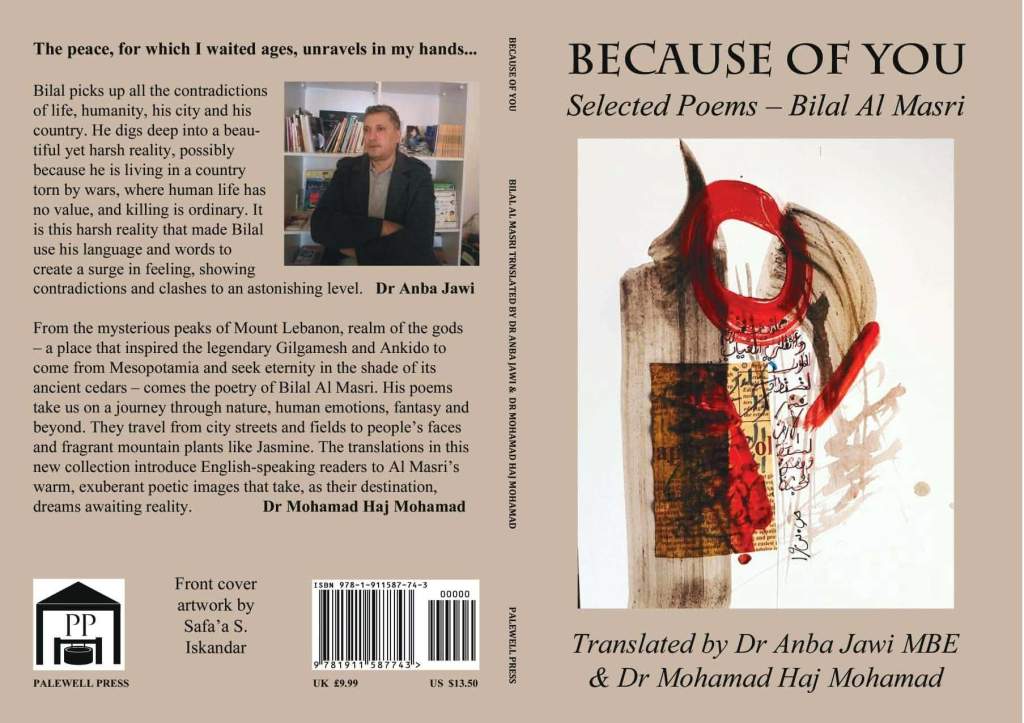
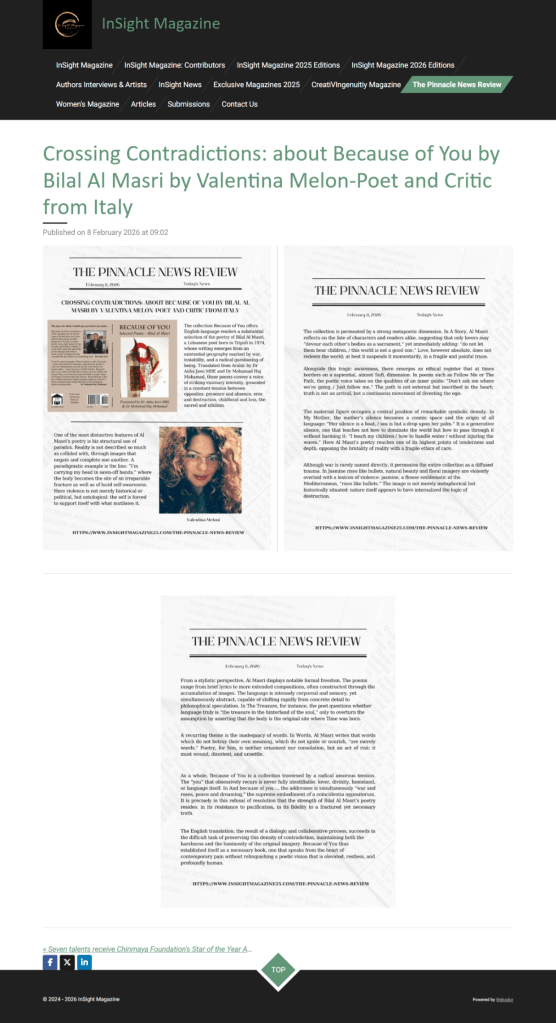




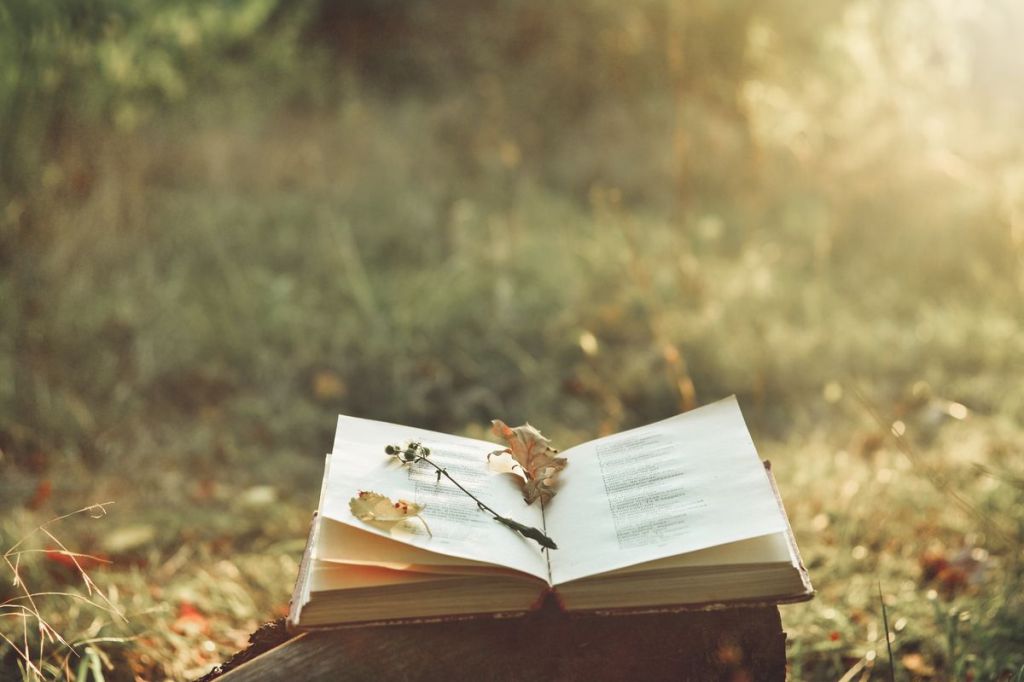

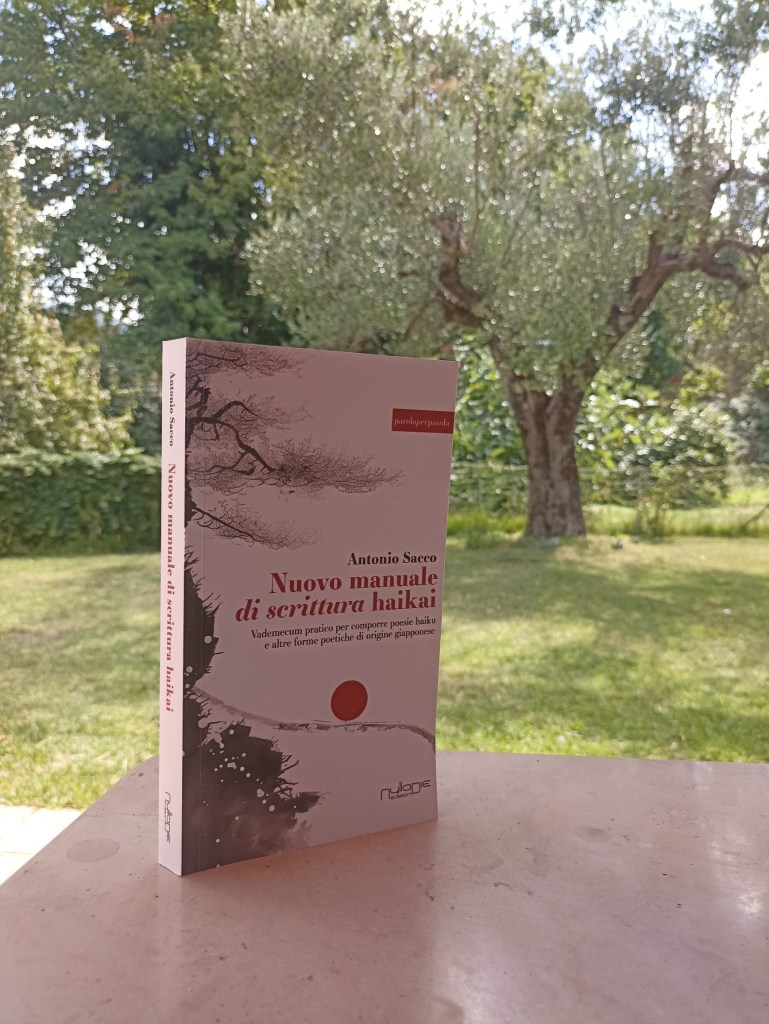

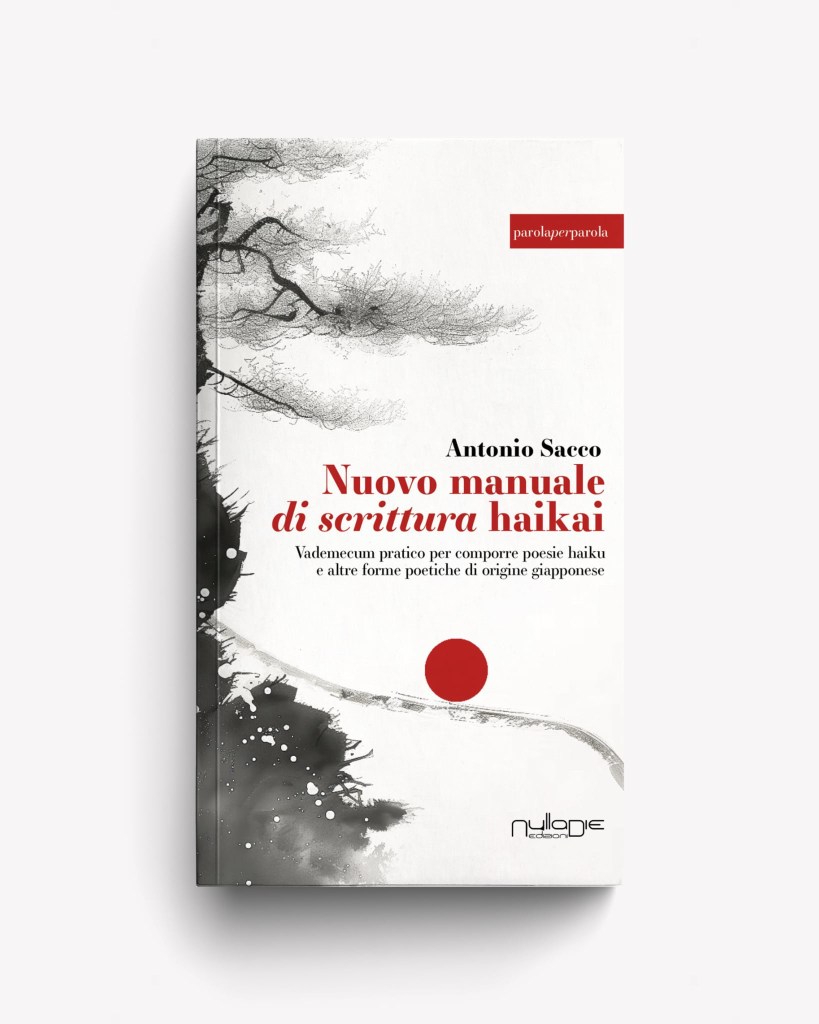










Devi effettuare l'accesso per postare un commento.